Il 21 gennaio 1921, con la Scissione di Livorno, nasceva il PCD’I, il Partito Comunista d’Italia, che avrebbe inciso sulla storia del nostro paese fino al 3 febbraio 1991 quando venne fondato il Partito Democratico della Sinistra.
A cento anni dalla nascita, e a trenta dalla sua fine, mentre il mondo è alle prese con l’epocale sconvolgimento del coronavirus, con i suoi effetti ben visibili nel presente, e ancora tutti da valutare nell’immediato futuro, e come paralizzati dall’enormità dei problemi, crisi della globalizzazione, crisi climatica, sovranismi, movimenti migratori su scala planetaria, diseguaglianze intollerabili, mancato pieno riconoscimento dell’imprescindibile ruolo delle donne, ha senso riflettere e ragionare sulla storia del P.C.I, su quello che è stato il più grande Partito Comunista dell’Occidente, magari per trarre qualche insegnamento o indirizzo, soprattutto per la sinistra nel mondo, per navigare in questo tempestoso momento storico?
A giudicare dalla miriade di articoli giornalistici, saggi su riviste, libri già pubblicati o in pubblicazione, trasmissioni televisive, l’interesse per quella storia che ha attraversato il Novecento, è molto alta, segno che è materia viva, che ha che fare con l’utopia possibile oggi. Potremmo definirlo “Socialismo possibile in una società complessa”.
La storia non si ripete mai allo stesso modo, ma insegna, e i parallelismi sono utili.
Gli anni del primo dopoguerra, quelli che vanno da 1919 al 1921, sono estremamente travagliati, come ogni periodo post bellico, mentre la Spagnola, pandemia planetaria, in poco più di due anni (1918/20) miete più vittime dello stesso conflitto mondiale appena concluso (circa 50.000.000 di morti).

Per l’Italia, con in suoi 600.00 morti, e le migliaia di mutilati e reduci che reclamano un lavoro, la guerra ha segnato una cesura netta con il periodo giolittiano del primo decennio del novecento. Lo stato liberale è in crisi, fragile la sua struttura, grandi movimenti di massa si affacciano sul palcoscenico del mondo, grandi partiti superano le vecchie consorterie risorgimentali. Tra il 1919 e il 1920 è il Biennio rosso: occupazione delle fabbriche e delle terre uniscono in un’unica istanza di rinnovamento la questione operaria e quella meridionale, laddove il latifondo permane. Il mito della Rivoluzione d‘Ottobre si estende in Europa e la Rivoluzione proletaria sembra possibile anche in Occidente.
“Tutto ha inizio a Torino” dicono gli autori di questo documentatissimo saggio che si muove tra storia e cronaca, dando spessore alle vicende umane di grandi protagonisti che hanno segnato la storia d’Italia, uomini e donne che hanno attraversato il Novecento, secolo di tragedie e di sogni, con ideali di cambiamento e cadute negli abissi. Tra questi protagonisti risalta nel libro la vicenda umana di Antonio Gramsci, le sue difficoltà economiche negli anni torinesi, il suo pudore nel mostrarle, lui che era arrivato nella grande città nel 1911 dalla lontana Sardegna, ma anche le opportunità offerte dall’Università dove insegnano professori prestigiosi. Ma per questo aspetto rimando alle straordinarie biografie di Giuseppe Fiori e alla, più recente, di Giuseppe Vacca.
Torino è la città che segna “la nascita del grande capitalismo industriale” e dove il modello fordista della catena di montaggio si applica al lavoro, la città dove gli operai si organizzano nel sindacato e guardano al Socialismo. Quel clima politico trova riscontro nelle elezioni del 1919, le prime a suffragio universale maschile e a sistema proporzionale: il PSI ottiene 156 seggi alla Camera, il PPI 100, i Liberali 96. A Torino c’è Giovanni Agnelli, l’inventore della FIAT, ma ci sono anche Einaudi e Gobetti, Gramsci e i giovani socialisti che fondano “L’ordine Nuovo”, la rivista che sarà l’incubatrice del nuovo partito, tra cui Palmiro Togliatti, Angelo Tasca e Umberto Terracini.
Gramsci e Gobetti, entrambi vittime del fascismo, si conoscono e si stimano. Partono da punti di vista analoghi: “Essi – dicono gli autori – vedono nelle officine Fiat, traboccanti di tecnologie avveniristiche, l’occasione di riscatto di un paese provinciale ripiegato sulla difesa di piccoli interessi…”(pag.58).
Divergono sulle prospettive: per Gobetti l’élite operaia torinese sarà, con progressivi movimenti dal basso, la base della futura borghesia produttiva che completerà quella rivoluzione liberale mancata nel processo risorgimentale, Gramsci “muove da una rivoluzione vera, quella sovietica appena avvenuta, e immagina che, partendo dai Consigli di fabbrica appena eletti da tutti i dipendenti, anche da quelli non iscritti a partiti o sindacati, sarà alla fine possibile costruire un modello di democrazia socialista basata sulla partecipazione e sul consenso delle persone”.
Ci si chiede, ed è una domanda che accompagna tutto il libro, come anche un tratto della sua lunga storia dopo il periodo della clandestinità durante il fascismo, come mai il PCI sia stato, fino agli novanta del secolo scorso, il più grande partito comunista d’Occidente, fino ad arrivare alla soglia del governo, mentre altri partiti comunisti in Europa siano stati sempre minoritari se non scomparsi.
Ciò è dovuto all’eredità gramsciana, e non è un caso che i due autori dedichino le prime cento pagine del libro a Gramsci e che lo comincino con queste affermazioni: “Per conoscere e capire questa grande storia, bisogna necessariamente partire da Gramsci. E da quell’autentico tesoro rappresentato dai Quaderni vergati a mano in cella, che ne rivelano il pensiero e la grandezza…ancora oggi oggetto di studio in tutto il mondo”. Fa riflettere il fatto che a scriverlo siano due giornalisti, attenti alle vicende della sinistra italiana e mondiale, ma non di formazione marxista. A conclusione del libro si legge: “Una sinistra che abbia voglia di ricominciare, non può che partire da Gramsci”.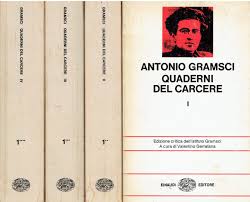
La sua visione critica e non dogmatica del marxismo, il suo ancoraggio alla Storia d’Italia, vedi nei Quaderni sue riflessioni su Macchiavelli, sulla Questione Meridionale, su Dante, su Croce, su Pirandello, il concetto di egemonia, americanismo e fordismo ecc…sono alla base del Partito Nuovo delineato da Togliatti al suo ritorno in Italia dopo 18 anni di esilio, la gran parte dei quali trascorsi a Mosca.
“Il compagno Ercoli sbarca a Napoli il 27 marzo 1944, barba lunga e maglione da marinaio..” ”Maurizio Valenzi (Sindaco di Napoli negli anni settanta) lo descrive così: è pallido e smagrito, più vecchio e stanco dei suoi 51 anni” (pag. 133).
L’11 aprile 1944, nel cinema Modernissimo di Napoli, Togliatti parla per 4 ore: è la “Svolta di Salerno”: (pag 137) “Bisognava – disse Togliatti – organizzare un partito di tipo nuovo aperto a tutti…dobbiamo unirci per ricostruire la democrazia”. Da qui la scelta e il ruolo unitario che il partito eserciterà nella Resistenza, nella scelta della Costituente, il ruolo decisivo nella elaborazione della Carta Costituzionale, l’attenzione al mondo cattolico, l’impronta laica ma senza alcun settarismo antireligioso, a cui “si atterrà in seguito anche Berlinguer”. Tutto questo non senza difficoltà interne da parte dell’ala filosovietica del partito, di molti dirigenti e militanti legati al mito della Rivoluzione russa e dello stalinismo, ed esterne da parte di forze politiche che vedevano nel Partito Comunista un corpo estraneo alla storia d’Italia. Si costruiva dunque un partito non antisistema, ma di governo.
I due autori seguono le vicende dei comunisti italiani, nelle scelte dei loro leader, nei loro errori e contraddizioni, una storia corale, perché nelle sezioni e nei luoghi della discussione, luoghi oggi inariditi dai social e quasi inesistenti, si riverberano i crocevia della storia del ’900. Particolare interesse suscitano le pagine dedicate ai contraccolpi all’interno del PCI del rapporto Chruščëv al XX Congresso del PCUS (24/25 febbraio 1956), con la denuncia dei crimini di Stalin (pag.120,121,122), i fatti d’Ungheria del 1956, con l’intervento dei carri armati russi a reprimere la rivolta popolare ungherese, i movimenti giovanili del 1968 e l’autunno caldo (segreteria Luigi Longo), la traumatica vicenda della radiazione del gruppo del Manifesto, la Primavera di Praga.
Pur nella oscillazione dei giudizi da parte del gruppo dirigente, che a volte si traduce in tardive prese di posizione rispetto a tali fatti, in un mondo diviso in blocchi e ancor in piena guerra fredda, il PCI mantiene i suoi consensi, e rafforza i suoi passi verso una via italiana ed europea al Socialismo.
C’é una linea di continuità, in questa storia, tra la famosa lettera di Gramsci del 14 ottobre 1926 al Comitato Centrale del Partito comunista sovietico sui rischi di come avrebbero potuto evolversi le lotte interne a quel partito, resa nota solo nel 1938, «compagni voi state distruggendo l’opera vostra…», e sul momento non condivisa da Togliatti che era a Mosca, il Memoriale di Yalta dello stesso Togliatti, pochi giorni prima di morire per un ictus, (21 agosto 1964), e l’intervento di Berlinguer al XXV Congresso del PCUS (Mosca 27 febbraio 1976).
Gli autori sottolineano il dato di cronaca “dopo il discorso di apertura di Bréžnev (24 febbraio), della durata di sei ore, Berlinguer dovrà aspettare quattro giorni prima di parlare…ha un quarto d’ora di tempo, ma già i cinquemila delegati del congresso conoscono il testo del discorso tradotto nelle varie lingue”, che segna il definitivo distacco dei comunisti italiani dal comunismo così come si era storicamente realizzato in Russia: “L’attualità del problema del socialismo ci impone […] di indicare con assoluta chiarezza quale socialismo noi riteniamo necessario e il solo possibile per la società italiana. Noi ci battiamo per una società socialista che sia il momento più alto dello sviluppo di tutte le conquiste democratiche e garantisca il rispetto di tutte le libertà individuali e collettive, delle libertà religiose e della libertà della cultura, delle arti e delle scienze. Pensiamo che in Italia si possa e si debba non solo avanzare verso il socialismo, ma anche costruire la società socialista, col contributo di forze politiche, di organizzazioni, di partiti diversi, e che la classe operaia possa e debba affermare la sua funzione storica in un sistema pluralistico e democratico” (pag 198, 199, 200).

Il libro segue il cammino di Berlinguer in questa sua ricerca, nella sostanza come “procedere lungo la via italiana al socialismo senza alcun condizionamento” (intervista a Giampaolo Pansa sul “Corriere della Sera” del 15.06.1976) nei vari frangenti storici, complessi e travagliati che lo hanno visto protagonista, il compromesso storico, Allende e il golpe cileno, il terrorismo, le stragi di matrice fascista, l’Alternativa democratica, “l’esaurirsi della capacità propulsiva di rinnovamento delle società, o almeno di alcune delle società che si sono create nell’Est europeo” (Intervista televisiva a seguito dei fatti di Varsavia del 12 dicembre 1981, citata a pag. 208), la Terza via, la Questione morale, fino alla sua morte improvvisa a Padova l’11 giugno 1984.
Al “ragazzo Enrico” vengono dedicate molte pagine (da 180 a 220) e dopo la sua morte si apre una fase di progressivo e inesorabile declino, a partire dalla caduta del Muro di Berlino (9 novembre 1989), e dal suo significato simbolico.
Il libro dedica alcuni capitoli, e dà la parola, a tanti dirigenti post comunisti che si sono alternati nella storia più recente, da Occhetto, che attuò la svolta del cambio del nome del PCI in Partito Democratico della Sinistra, a Prodi, Veltroni, D’Alema, e altri fino ai giorni nostri, alcuni dei quali hanno avuto anche responsabilità di governo. Il loro errore più grave è stato quello di avere abbandonato il proprio campo di ricerca e di azione, e di aver abbracciato teorie economiche e pratiche politiche del campo avverso. Per esempio l’aver abbracciato le idee dei New Democrats di Bill Clinton e Tony Blair, il quale “si è innamorato dell’idea che il nuovo capitalismo finanziario diventerà, insieme ai prodigi dell’economia digitale, l’alleato naturale dei partiti democratici di centro sinistra nella loro missione di modernizzare le vecchie società industriali” (pag. 261)
Così come, avendo abbandonato il proprio campo di ricerca e di studio dei fenomeni in atto non ci è resi conto delle “Macerie della finanza creativa” (titolo dell’ intero capitolo 20, da pag.247 a pag. 255), delle vittime del Neoliberismo, delle nuove e insopportabili diseguaglianze, su cui i populisti hanno spesso costruito i loro consensi.
In un recentissimo libro (“La metamorfosi”, Laterza 2021) Luciano Canfora si chiede “Oggi non è più tempo di recriminazioni o di puntualizzazioni storiografiche. La domanda è solo una: potrà la odierna socialdemocrazia (fenomeno in prevalenza europeo), scoordinata com’è e frastornata, reggere alla prova della vittoria planetaria del capitalismo finanziario?”
Forse la risposta la si può avere recuperando la memoria. Il libro di Mario Pendinelli e Marcello Sorgi, si conclude con una preziosa e lunga testimonianza di Umberto Terracini, uno dei componenti del gruppo dell’Ordine Nuovo, realizzata da Pendinelli nel 1981.
Tonino Sitzia
20 febbraio 2021



Ho trovato molto interessante la recensione. La storia del Partito Comunista Italiano è ricca di idee, azioni e interventi che si intrecciano con gli eventi del diciannovesimo secolo. La recensione si potrebbe integrare rimarcando il rapporto che il Partito ha avuto con la “Cultura”. Più in generale, si può affermare che questo rapporto si coniughi con l’esistenza di una precisa “politica culturale” adottata nel dopoguerra, che porta il Partito ad avere una vera “egemonia” nella cultura italiana, anche al di là delle posizioni politiche. In questo ambito, per l’importanza attribuita alle arti e all’istruzione, il partito seppe andare oltre la dimensione ideologica, riuscendo a definire una precisa azione e a realizzare un profondo legame con gli intellettuali, come letterati e artisti, ma anche con professori, docenti, studenti, attori, musicisti e altre figure. In tal senso, vorrei ricordare una bellissima frase di Gramsci: “Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che i nostri rapporti hanno con gli altri uomini”
Importante e puntuale intervento quello di Antonio Sitzia: la recensione su “Equilibri” del libro “Quando c’erano i comunisti. I cento anni del PCI tra cronaca e storia” di Mario Pendinelli e Marcello Sorgi.
Quante sciocchezze e semplificazioni superficiali si sono sentite e scritte in questo inizio d’anno sul PCI a cent’anni dalla sua nascita.
Condivido le tue considerazioni, il tuo argomentare, Tonino.
Leggerò quest’opera e leggerò il libro “La metamorfosi” di Luciano Canfora, anch’esso fresco di stampa.
Voglio anche ricordare di Guido Liguori “La morte del PCI”, libro uscito nel 2009 per “manifestolibri”: una seria, dettagliata e documentata analisi, del percorso che portò al disfacimento di quel partito (il più grande partito comunista dell’Occidente) – una sorta di morte annunciata.